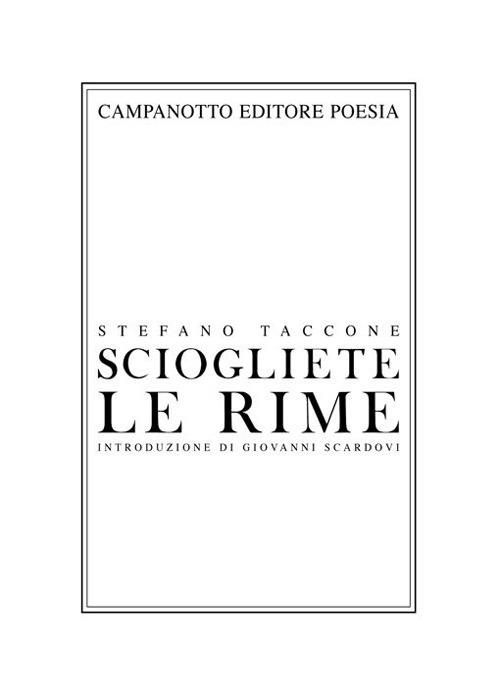Confrontarsi con uno scrittore riguardo alla sua opera poetica è un privilegio: i dubbi che attanagliano possono essere sciolti, come i nodi di un’ancora che deve essere rilasciata affinché la nave dei versi sia ben salda. Ho l’occasione, pertanto, di ospitare sull’Incendiario Stefano Taccone, per dialogare con lui sulla sua ultima pubblicazione, Sciogliete le rime (Campanotto Editore, 2023): una raccolta in cui la poesia e il nostro realismo dai tratti effimeri, ambigui e surreali si fondono, sotto il segno della raffinatezza e della ricerca metrica e ritmica.
Ti do il benvenuto, Stefano Taccone, tra le nostre pagine, e voglio sciogliere in modo diretto il primo nodo della tua barca poetica: utilizzi, nella raccolta, un verso semilibero (alternandoti solitamente tra senari e settenari) con poca punteggiatura, cadenzato e scandito da altalene ritmiche (rime, consonanze e assonanze). Tenendo conto di questo, sciogliamo il primo nodo: come mai hai scelto questo titolo, Sciogliete le rime (oltre a essere la poesia eponima in explicit della raccolta)?
Intanto grazie a voi dell’invito e della calorosa accoglienza! Mi piace fare riferimento a modi di dire consolidati, ma senza citarli interamente, bensì modificandoli leggermente. Questo produce uno slittamento di significato ed un conseguente cortocircuito nel lettore. È il caso di un titolo del genere.
Premetto che la mia poetica – oltre che la mia stessa visione del mondo – implica la convinzione dell’impossibilità di sciogliere tutti i nodi. Alcuni si possono solo allentare. Altri magari potranno essere sciolti, ma produrranno – quasi fosse un effetto collaterale – un altro nodo, a sua volta da sciogliere, e così via potenzialmente all’infinito…
Molti hanno inteso l’imperativo del titolo come un semplice invito a smettere di scrivere cercando la rima, sia essa baciata, alternata, incrociata etc. Non mi riconosco troppo in questa interpretazione. Qualche tempo fa udì dichiarare ad un poeta italiano più anziano di una generazione rispetto alla mia che non usava il verso libero, ma si basava ancora sulla metrica, perché non si potrebbe parlare di poesia se il testo non possiede un ritmo, e creare un ritmo senza contare le sillabe gli appariva un’impresa per poeti troppo più bravi di lui, un qualcosa che eccedeva le sue potenzialità. Io dico lo stesso a proposito della rima: è l’espediente che adopero per conferire il ritmo al brano, perché temo di non essere capace di fare lo stesso senza di essa. Viceversa la mia metrica nella migliore delle ipotesi è empirica. Cerco un equilibrio congruo, ma sempre vario. Non conto le sillabe sulle dita!
Non è questo, tuttavia, l’unico motivo per cui adopero la rima, o anche la consonanza e l’assonanza. Ce n’è un altro di importanza almeno pari, questa volta strettamente legato all’ambito dei messaggi che intendo trasmettere. La rima, retaggio di una poesia alta, è assolutamente funzionale ai miei fini ironico-demistificatori. Usare la rima parlando di cose deliberatamente di poco conto – o apparentemente tali -, di cose che neppure oggi – anche se meno di ieri – entrerebbero nel discorso poetico – gli orsacchiotti ispirati ad un celebre spot pubblicitario di pile; una vasca da bagno foderata di savoiardi; un presunto licantropo che si scopre una bestiola indifesa… – va in questa direzione.
Pertanto, quando ho esortato a “sciogliere le rime” chiedendo ad un voi generico “un favore che non vi so fare”,è come se avessi chiesto di aiutarmi a desistere dallo scrivere ancora, o almeno dallo scrivere ancora poesie, ché scrivere rime e scrivere poesie sono per me due azioni che si identificano. Perché l’ho chiesto? Perché smettere di scrivere in certi momenti mi appare quasi un atto liberatorio. Scrivo – tra l’altro – per sopportare la realtà, ma nel momento in cui questo bisogno venisse meno potrebbe corrispondere alla circostanza per cui il fuori da me è diventato finalmente più vivibile. Inoltre, permane la “mezza illusione” che mettere alla berlina ciò che non piace possa aiutare a debellarlo. In alcuni momenti invece si prova la totale inservibilità della scrittura – almeno della mia – entro una prospettiva di cambiamento, quando non sorge proprio il sospetto che, anche solo nominando ciò che detesti, non fai che rafforzarlo.
Nella poesia in explicit, inoltre, consigli di sciogliere le rime come ultimo atto di conforto prima di un’imminente fine del mondo, dominato dal fuoco e dai gas nocivi. Come può la poesia, quindi, avere un ruolo salvifico? E cosa simboleggiano il fuoco e i gas nocivi nella tua raccolta poetica?
Credo di aver già risposto in parte. La mia risposta è prettamente soggettiva. Scrivere poesia nella migliore delle ipotesi è una pratica salvifica per me stesso; tutt’al più per qualche sporadico lettore che mi apprezza. Non vedo altro modo, per la mia poesia, di esplicare un ruolo salvifico. Può darsi sia così anche per altri. Eppure anche per poeti che magari sono legati a ben altri numeri rispetto a me non vedo molte possibilità di salvezza oggettiva, ovvero non mi sembra attualmente possibile pensare ad una poesia che cambi il mondo, la società, la storia. O almeno non in una direzione che reputo positiva.
Lo stesso direi per tutte le altre arti, sia quelle più tradizionali, sia quelle più giovani. Non sono sicuro che sia sempre stato così. Ancora fino alla metà del secolo scorso forse qualche spiraglio in più esisteva. Cosa è cambiato? Si tratterebbe di imbastire un discorso enorme, che esula dalle possibilità che ho in questa sede. Mi limito ad affermare che con la rivoluzione industriale si è verificato un lento ma costante declino della centralità di ciò che nel 2023 chiamiamo arte. La stragrande maggioranza dei linguaggi che influenzano l’uomo contemporaneo non è convenzionalmente oggi ricondotta a ciò che più comunemente annoveriamo tra i linguaggi artistici.
Mi chiedi infine cosa simboleggiano nella mia raccolta il fuoco e il gas nocivi. Mi verrebbe da rispondere che innanzi tutto simboleggiano essi stessi. Siamo di nuovo in estate. Le piogge e il freddo anomali di maggio-giugno nel momento in cui scrivo ci stanno garantendo una stagione fresca. Ma c’è qualcuno che crede davvero che arriveremo a settembre senza che ettari ed ettari di boschi andranno puntualmente in fumo? Nel frattempo, è un anno e mezzo che parliamo costantemente di guerra e la minaccia nucleare è ritornata “di moda” in un battito di ciglia. Grandi catastrofi di genesi antropica marciano minacciosamente verso di noi man mano che il tempo scorre, quando non sono già di bruciante attualità – come avviene in alcuni dei paesi più poveri, specie africani, che io rifiuterò sempre di chiamare “in via di sviluppo”. Ma il peggio è che ormai sembra palese l’incapacità del genere umano di invertire la rotta. La lotta al cambiamento climatico, la transizione ecologica e digitale (sic) non mi paiono che – magari talvolta anche in buona fede – gli ennesimi espedienti per perpetuare la logica del capitalismo assoluto, l’unico dogma che non va messo in discussione. Purtroppo, Mark Fisher è scomparso già da sei anni. Il suo Realismo capitalista è già quattordicenne. Ma le sue tesi sono destinate ad accompagnarci ancora per molto e probabilmente sopravviveranno anche a noi.
A proposito di fuoco, anche tu hai un Incendiario all’interno della tua raccolta, nel quarto intermezzo in prosa dal titolo Draghetto ad effetto, in cui scindi la personalità di un ex sessantottino, che un tempo è stato incendiario e ora si sente pompiere, paragonandolo al draghetto Grisù, aspirante pompiere, e a suo padre, Incendiario, protagonisti del famoso cartone animato andato in onda nella metà degli anni ‘70. Sciogliamo il terzo nodo, e ti domando: cosa vuol dire, per te, essere Incendiario? Tu sei un Incendiario?
Probabilmente nei decenni che hanno seguito gli anni Sessanta–Settanta il binomio incendiario-pompiere è stato adoperato per alludere al fenomeno degli ex contestatori che si erano ben integrati nel sistema. In tal senso da incendiari erano divenuti pompieri. Quanto questo passaggio costituisca un tradimento che grida scandalo e quanto invece un passaggio più lineare di quanto possa apparire continua ad essere oggetto di discussione. Sicuramente la prima delle due opzioni è quella che riesce più facile abbracciare, ma è anche quella meno affascinante. La seconda è quella tipicamente adottata ne Il nuovo spirito del capitalismo (1999) dai sociologi Luc Boltanski ed Ève Chiapello, che allo scadere del secolo scorso evidenziano quanti manager arrivati sulla cresta dell’onda negli anni Novanta intendano il loro percorso in assoluta continuità con la formazione giovanile avvenuta nell’alveo della contestazione. Questo per non parlare delle provocatorie tesi di Valerio Magrelli o di Mario Perniola, autori rispettivamente di due libri con evidenti affinità, Il Sessantotto realizzato da Mediaset e Berlusconi o il ’68 realizzato, curiosamente usciti entrambi nel 2011.
Detto questo, se devo rispondere circa la mia identità di incendiario o pompiere la faccenda si complica. Stando alla classificazione generazionale attraverso la quale, come ho raccontato, fraintendevo in un primo momento la natura del conflitto tra Grisù e il padre, io dovrei essere più pompiere che incendiario. Dovrei essere un pompiere figlio di (ex) incendiari. Questa rappresentazione è però insieme più congrua se riferita a venti anni fa che ad ora e congrua fino ad un certo punto anche se riferita a vent’anni fa, nel momento in cui si considerano quei formidabili incendiari che furono i no global! Ed io ai tempi del movimento di Seattle e di Genova ero appunto intorno alla ventina, ovvero nell’età incendiaria per eccellenza.
Infine, mi risulta davvero ostico rispondere ad una domanda del genere perché si rischia di essere risucchiati in un’ottica prossima a quella delle ormai anacronistiche – piaccia o meno – categorie novecentesche: destra e sinistra, riformisti e rivoluzionari, conservatori e liberali. Tutte etichette che magari si adoperano oggi più di prima, ma che non di meno appaiono completamente svuotate di senso. Mettiamola così: cerco di surriscaldare il clima, di mettere un po’ di pepe nello scialbo conformismo che ci pervade, ma sto attento a non trasformare le scintille in un incendio, perché una volta che lo hai appiccato non è più controllabile e il primo a bruciare vivo potrei essere proprio io.
Dialoghi, sicuramente, con te stesso all’interno della poesia: il poeta, l’insegnante, il pessimista, l’osservatore, l’accusa, la difesa, autocritiche, autoriflessioni. Quante versioni di te ci sono nella raccolta?
Sicuramente è presente la classica scissione tra l’essere e il dover essere. Tra la tendenza a pensare, dire, fare in un certo modo e le pressioni nefaste cui devi sottostare per vivere. Ma la poesia in questo è una sorta di vendetta nei confronti di tutti coloro che esercitano poteri coercitivi, che vogliono soffocare la libertà e la fantasia per motivi non facili da mettere a fuoco, ma certamente anche perché essi hanno castigato innanzi tutto in se stessi tali facoltà, e non è detto che ne siano consapevoli.
Se vi sono tante versioni di me vuol dire che sono riuscito a lambire almeno un po’, se non proprio a cogliere, la complessità dell’umanità contemporanea, e non solo contemporanea. Credo, d’altra parte, che quelle che possono apparire varie versioni non siano affatto troppo difficilmente riconducibili ad una personalità relativamente unitaria. Così come credo che in una o più versioni alcune persone – anch’essi poeti e/o scrittori oppure semplici lettori – si possano riconoscere, possano trovare una voce che è anche la loro. Talvolta ricevo riscontri di questo tipo e mi dico che ho fatto bene a desistere ancora unpo’ dallo “sciogliere le rime”.
Tra i tuoi versi si instaura un legame forse nuovo in poesia tra l’armonia poetica e le assurdità del nuovo (Televisione, Smartworking, Covid, App, Dad e tanto altro): come nasce questo legame, tra le funi della poesia e gli stracci del Duemilaventitré?
Non saprei dire se ci troviamo di fronte ad una novità. Di solito, anche quando entri nella convinzione granitica che un qualcosa sia nuovo, prima o poi vieni a scoprire non dico che quel qualcosa è stato già fatto, ma almeno che è meno innovativo di quanto tu abbia potuto credere in principio. Se si trattasse davvero di qualcosa di nuovo perciò tanto meglio!
L’armonia non è un obiettivo che mi pongo, o almeno non prettamente e non nell’accezione più convenzionale del termine. Piuttosto cerco – quello sì – un equilibrio, ma, onde eludere il già sentito e il già detto – per quanto possibile – tale equilibrio deve essere svolto attraverso molteplici variazioni.
Il mio interesse è di carattere sociale. Parto dalla mia vita, ma cerco di recepire le inquietudini del mio tempo e credo che la poesia vada assolutamente “sporcata” da tutto ciò. Questo la rende vera. Attraente per me nel momento in cui la scrivo e forse anche per qualcuno che legge. Naturalmente quando parlo di vero non intendo riallacciarmi ad alcuna poetica “neorealista”. Per vero intendo una totalità non filtrata attraverso la distinzione tra ciò che è presuntamente “poetico” e ciò che, sempre presuntamente, non lo è, così come non alludo solo alla realtà che abbiamo immediatamente sotto gli occhi, ma anche al sogno, all’immaginazione… La deformazione, l’iperbole, la sovraesposizione costituiscono inoltre parte integrante, direi irrinunciabile, delle mie strategie di espressione del vero.
Ho voluto fare un gioco, trovare una lirica che potesse rappresentare a livello collettivo le altre e il significato dell’opera. Nella ricerca, sono stato inondato da La pioggia di mezzo secolo, scegliendola come rappresentante delle sue poesie amiche. Con questa lirica, sciogliamo uno degli ultimi nodi: come ci si può salvare da questa pioggia delle retoriche, del pacismo blaterato e del confusionismo del nostro mezzo secolo?
«[…] Non domandarci la formula che mondi possa aprirti
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo».
Rispondendo con questo celeberrimo frammento adopero ancora Eugenio Montale e vado a ritroso di un altro mezzo secolo. La poesia è del 1923. Dunque, risale esattamente ad un secolo fa. Possibile che a distanza di cento anni sia ancora appropriata per alludere al nostro tempo? Direi che è quasi terribile, eppure è proprio così,anzi lo sembra più ancora di quando è stata scritta.
Il Novecento è stato anche un secolo di grandi speranze. La prospettiva del superamento del capitalismo verso una società assai più vivibile, persino gioiosa, basata sulla fine delle gerarchie, dell’oppressione dell’uomo sull’uomo… Tutto questo ha mobilitato masse; ha prodotto certo anche enormi orrori, ma ha conferito un senso forte a tante vite. La prospettiva di un “sol dell’avvenire” – si può ancora usare questa espressione dopo l’appropriazione da parte di Nanni Moretti? – costituiva una condizione nella quale pareva che i suoi raggi spesso e volentieri già intervenissero a riscaldare. Un po’ come le estasi dei santi, che sono state descritte a mo’ di anticipazioni delle beatitudini paradisiache.
Crescentemente, tuttavia è apparso chiaro che quel paradiso non sarebbe mai arrivato, e così sono scomparsianche i suoi momenti di prefigurazione. Si potrebbe obbiettare che bisogna adattarsi al mondo così com’è e che non esisterà mai un mondo perfetto. Almeno la seconda delle due affermazioni è vera, naturalmente. Ma è vero anche che il fallimento di una teleologia anticapitalista ci ha lasciato completamente sguarniti di fronte alle ingiustizie vecchie e alle catastrofi nuove. Da qui il blaterare di chi non conosce la storia e di chi non ha neanche interesse a tenere conto dei suoi insegnamenti, giacché se sapesse – e volesse – leggerla si renderebbe conto di quanto certe evocazioni e similitudini per esortare a credere in un futuro migliore – o in quello che la narrazione dominante ci chiede di desiderare qualefuturo migliore – «non stanno in piedi neanche se le impali», come cantaFrankie Hi-Nrg in Giù Le Mani da Caino (1997), un brano che è peraltro zeppo di parole energiche contro alcune retoriche tipiche di un quarto di secolo fa, ma che non sono affatto archiviate.
Chiudiamo con l’ultimo nodo, la domanda che poniamo a tutti i nostri ospiti: chi è il tuo Incendiario, ovvero il libro e il suo autore che consiglieresti di leggere a un lettore esordiente?
Difficile indicare un libro per un lettore esordiente in astratto, a prescindere dalla sua identità. Non sapendo che età ha, quali sono i suoi interessi e disinteressi etc. Tuttavia, se penso ad un libro “incendiario” mi viene subito in mente La società dello spettacolo(1967) di Guy Debord. L’ho amata fin da quando l’ho scoperta, anche se non ho compreso subito tutto, e continuo a ritenerla un punto di riferimento imprescindibile per il mio cammino. Accanto a Debord porrei però l’intera Bibbia cristiana – tutti i libri dell’Antico e del Nuovo Testamento. Di primo acchito un tale accostamento potrebbe risultare spiazzante, persino apparire contraddittorio. Ovviamente so anche io che la distanza esiste, ma non per questo credo di stare accostando il diavolo all’acqua santa, come invece superficialmente fin troppi potrebbero ritenere. La Bibbia va (ri)scoperta al di là di quello che si può ricordare dai tempi del catechismo, ove si dà «da bere latte, non un nutrimento solido» (Corinzi 3, 2).
Ringraziando tantissimo Stefano Taccone per questo dialogo, ricordiamo che la sua raccolta Sciogliete le rime (Campanotto, 2023) si può richiedere in libreria, su Amazon e IBS.
E tu: hai da poco pubblicato un testo e vorresti farlo leggere all’Incendiario? Scrivici tramite email: redazione.incendiario@gmail.com